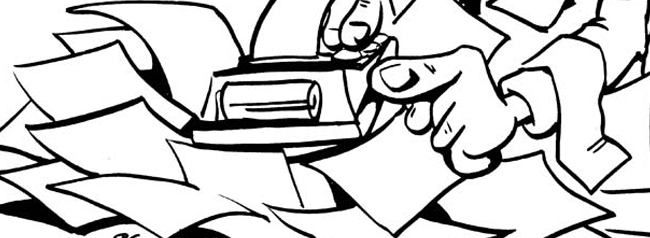La lettura dell’articolo “Luci e ombre dell’Italia che produce” di Severino Salvemini, ordinario di organizzazione aziendale in Bocconi, è da stimolo per il team di ENESSERE nel proseguire nel percorso di crescita intrapreso: siamo un buon esempio imprenditoriale (e con noi, moltissime altre piccole realtà) che tenta di resistere all’inevitabile declino che purtroppo, sembra aver contagiato il nostro paese.
“Ho fatto un sogno. In un’azienda dall’architettura contemporanea i magazzini sono vuoti e nei piani superiori molte scrivanie sono deserte. Negli uffici invece popolati, alle 7 di pomeriggio lavorano ancora freneticamente impiegati e dirigenti. Vestono informalmente e parlano poco tra loro, mentre in alcune sale riunioni qualche gruppo di persone assiste ad una proiezione di slides. Non c’è alcun rumore, non si sentono parole.
La morale del sogno? Può essere una, ma anche il suo opposto: angoscia o serenità.
Potrebbe essere un’azienda dove molti dipendenti sono in cassa integrazione, perché il mercato e gli ordini sono da mesi in strutturale declino e il magazzino senza merce ne è la dimostrazione evidente. E i pochi che rimangono devono supplire al superlavoro burocratico, perché la ristrutturazione incombente li ha schiacciati in una relazione gerarchica dominante che non può essere rifiutata, pena il loro allontanamento. Coloro che sono nelle sale riunioni continuano a perpetrare la stanca ritualità dei gruppi di lavoro, alla ricerca di decisioni sempre più difficili da assumere, quando l’atmosfera diventa rassegnata e rinunciataria. Anche il look dei lavoratori, senza più attenzione alla formalità dell’abito, tradisce una scarsa attenzione all’estetica e una sciatteria che segnala ormai uno scarso amor proprio.
Ma l’interpretazione del sogno potrebbe essere esattamente il contrario. Il magazzino non serve più perché l’organizzazione ha saputo progettare una supply chain in cui tutto viene movimentato da una logistica reticolare che poco incide sulla necessità di avere merce in sede. Molti dipendenti sono assenti fisicamente dal luogo di lavoro perché la connessione senza fili consente una professionalità in remoto, evitando costose trasferte di pendolarismo e migliorando la qualità della vita dei lavoratori. Alcuni prolungano volentieri il loro orario, perché sono identificati in un progetto imprenditoriale visionario e coinvolgente e sono ben lieti di contribuire con la loro creatività ad missione aziendale, in cui i loro capi li hanno coinvolti in una relazione di empowerment. I gruppi di lavoro stanno scambiandosi competenze e buone pratiche di risoluzione dei problemi sulla base di un valore di condivisione delle conoscenze che è per loro gratificante e motivante in termini di sviluppo professionale. L’abitudine a vestirsi in modo informale tradisce una cultura organizzativa che privilegia norme di comportamento basate sulla professionalità piuttosto che sul rango gerarchico o sull’anzianità.
Questo sogno è la metafora della nostra situazione economica attuale, fatta di molte ombre e di molti nodi irrisolti, ma anche di luci e di alcuni primati, che purtroppo la nostra scarsa autostima del momento finisce per farci dimenticare e far ricadere sotto una soglia di definitiva rassegnazione. Siamo stati colti dalla crisi del 2007 , quella successiva all’impennata delle insolvenze dei mutui subprime degli Stati Uniti, quando l’Italia stava completando il percorso di modernizzazione istituzionale (la deburocratizzazione, la riforma fiscale, la flessibilizzazione del mercato del lavoro, l’efficientamento della giustizia civile, il ringiovanimento del modello formativo). E il sistema aziendale, che stava faticosamente cercando di rimettere in moto un percorso di crescita si è inceppato in una spirale viziosa. I punti dolenti della nostra economia sono diventati l’alibi di un paese immobile, in cui le persone hanno finito per deresponsabilizzarsi e – quando esprimono carattere attivo – per rifugiarsi nel divieto.
Intrappolati quindi nel declino? Ma il nostro Paese ha spesso saputo rinascere (ci ricordiamo ancora le premesse dell’ultimo “miracolo” italiano?) e pertanto dobbiamo solo trovare un po’ di spinta e un po’ di caparbietà per rinforzare le esperienze positive e per abbandonare definitivamente quelle negative. Per ridiventare padroni del nostro futuro.
Occorre però metterci d’accordo su cosa intendiamo oggi – nella seconda decade dell’attuale secolo – per crescita. Quella che ha la ricchezza materiale come unico parametro di riferimento? Sicuramente no. Meglio liberarsi in fretta da questa idea e sposare un concetto di crescita in grado di porre le condizioni perché il domani tenda ad essere migliore dell’ oggi. In questa prospettiva è opportuno distinguere quali elementi ci danno speranze per una impresa prospetticamente eccellente e quali invece dovrebbero essere cancellati dal nostro tableau de bord. In poche parole, ciò che è cattivo e ciò che è buono.
Le cose da abbandonare
Nell’economia reale il gioco non si fa solo sulle condizioni esterne, ma si conduce sulle scelte interne, sui processi di impresa, sulle mosse aziendali, sugli acumi del top management. Aspetti che nell’ultima decade hanno determinato lo smarrimento nelle decisioni e il tentennamento dei gruppi dirigenti impauriti e senza visioni, tutti in attesa di condizioni di business environment più favorevoli. Con conseguenti scarse occasioni di sano azzardo imprenditoriale e di lanci di cuore oltre l’ostacolo.
Tutto ciò è visibile nelle grandi dimensioni di impresa. Lì il management ha comportamenti più tardivi rispetto ai cugini internazionali. Le strategie sono troppo poco determinate e affini a convenienze di breve termine; gli sviluppi del capitale umano sono basati su investimenti formativi esili che producono competenze poco originali e distintive (l’investimento in formazione delle imprese nazionali è da anni sotto l’1% del fatturato annuo); i disegni organizzativi sono rudimentali e burocratici; la direzione è autoreferenziale, poco mobile e scarsamente orientata al rischio e all’apertura (basta calcolare la diffusione dei sistemi di incentivi manageriali basati sul raggiungimento reale degli obiettivi target e se ne avrà la riprova); la governance aziendale si tramanda senza confronti e inclusioni esterne, con estensioni di patti di controllo, piramidi societarie e forme di potere insindacabile; la creatività di cui tanto si parla nello stivale del bello e del ben fatto non è altro che un pizzico di ritocco incrementalistico senza strappi di discontinuità o di radicale innovazione. Il tutto condito da una scarsa patrimonializzazione, resa ancora più traballante dalla fuga dei cosiddetti “animal spirits”, che durante la crisi hanno preferito la rendita immobiliare alla scommessa manifatturiera. Serve un nuovo ripensamento per l’industria di maggiori dimensioni, oggi decisamente incongrua rispetto al fabbisogno contemporaneo di competitività.
Le cose da nobilitare
Accanto a questo quadro non certo rassicurante, qualche parola più positiva sulle aziende di dimensioni minori, sulla solidità del loro modello di governance famigliare (spesso bistrattato come condizione di arretratezza dagli economisti, quasi che la sovrapposizione tra famiglia e diritti di proprietà rappresenti solo conseguenze negative, senza ricordare il vero punto di forza di una “gerarchia” che si accompagna a linee corte di comunicazione e di comando) e sui nuovi distretti che hanno cambiato pelle. I progressi e lo sforzo di reinventarsi vanno infatti riconosciuti. E danno speranza che, nonostante tutto, alcuni attori non si sono nascosti dietro gli “ismi” della crisi e del passato e sono riusciti a liberarsi da alcuni deficit di concorrenzialità, che come abbiamo scritto ancora sono assai presenti nell’economia delle massime dimensioni.
Il volo del calabrone di passata memoria, quello che era riuscito a sottrarre l’industria borghigiana dal trend recessivo, si è anch’esso fermato e alla fine del Novecento il localismo ha dimostrato le sue debolezze, che di fatto rappresentano in scala i problemi dell’economia italiana. Il modello del “piccolo è bello” sembrava al capolinea e le piccole imprese, cresciute con la vocazione di subfornitura, hanno dovuto ripensare il loro sviluppo sulla fase manifatturiera della filiera, riesaminando le fasi a monte (invenzione e valorizzazione delle idee) e a valle (commercio, marketing, logistica, distribuzione). Così facendo hanno fatto leva sul potere del mercato con nuove reputazioni e nuove marche distintive collettive. Dalla famosa strategia delle punture di spillo del secolo scorso (“forti pigmei e deboli watussi”, diceva Becattini nel lontano 1979), il patrimonio cognitivo si è allontanato dal provinciale, ricercando input professionali di origine planetaria. E il nostro sistema produttivo, pur negli anni durissimi della crisi, ha stretto i denti e ha prodotto controtempo una profonda evoluzione del modello d’impresa. La tenuta e il rilancio del neo-distretto sono legati all’emergere di un nuovo soggetto campione sul territorio: la media impresa che costituisce la chiave di volta di un complesso e faticoso processo di riorganizzazione avvenuto in questi ultimi dieci anni. Alcuni nomi sono evidenti: si chiamano Zegna, Lavazza, Campari, Brembo, Geox, Diesel, Tod’s, Sofidel, Fiamm, Amplifon, Coesia, Marazzi, Danieli, Sacmi, Indesit, Permasteelisa.
L’aspetto più evidente dello scavallamento del nuovo secolo è stato il rinnovo del know how distintivo, che è riuscito a cogliere la deriva postindustriale. Dopo un lungo periodo di fordismo e di ciminiere, la piccola e media imprenditoria ha imboccato l’evoluzione verso l’intangibile del mercato, dove i prodotti e i servizi si trasformano, incorporando sempre di più una parte preponderante di utilità immateriale e di evocazione simbolica. Il territorio ha prodotto nuove competenze (negli imprenditori, nei dipendenti, ma anche nei commercialisti, nei softwaristi, nei notai…). Un nuovo distretto economico che è riuscito a passare per un “guado” contemporaneo, dove le nuove idee, la creatività, l’inventiva, la capacità di applicare le dinamiche knowledge-based costituiscono l’unica fonte di vantaggio comparato di lungo periodo.
Nelle piccole dimensioni e nel territorio illuminato, ci sono molte soluzioni da nobilitare. E’ forse lì che il made in Italy è stato maggiormente colto e metabolizzato. E’ forse lì dove è avvenuta di più la sostituzione del capitalismo industriale con il capitalismo culturale. E’ lì che c’è stato un epocale cambiamento della politica industriale, trasformando l’economia locale da “eredità” a “progetto” e aiutando l’evoluzione a non intendere più il distretto come elemento storico-geografico del Paese e come aspetto di sola natura spontanea e auto organizzata. Da nobilitare e da replicare c’è perciò anche il contributo che il nuovo business model sta producendo in termini di policies per l’innovazione.”